top of page

MUSICA CRISTIANA
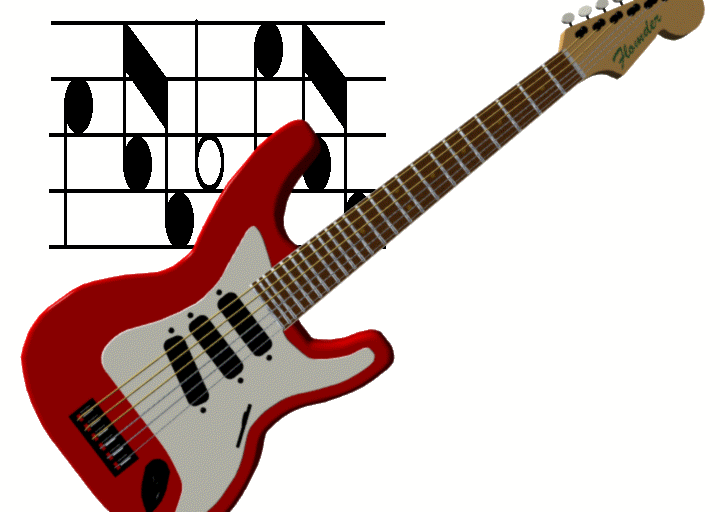

La diffusione del cristianesimo, e quindi del canto cristiano, ha avuto un ruolo decisivo nella storia della musica occidentale. La musica corale ha origine dal canto cristiano dei primi secoli. Nelle sacre scritture si legge che il canto era una pratica comune anche nei riti della religione ebraica: lo stesso Cristo, insieme ai suoi discepoli viene ritratto come "cantore": « E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. » (Marco, 14, 22-26)
Si può fare un parallelo tra la funzione della musica nei riti delle prime comunità cristiane e la funzione dell'arte decorativa, sintetica e stilizzata, degli inizi della vita ufficiale del cristianesimo (dopo il 313 d.C.). In entrambi i casi gli argomenti di fede sono l'argomento di espressioni artistiche non verbali che potevano essere facilmente ricordate anche da una congregazione non letterata e di umili origini.
Questo modo di "cantare le idee" continuerà nei secoli a contribuire alla partecipazione del fedele all'azione sacra, anche dopo che la lingua latina aveva da tempo cessato di essere comprensibile. Col tempo alla funzione ieratica (associata al salmodiare del celebrante) didascalica e partecipativa della musica si aggiunse anche una funzione decorativa tesa a solennizzare gli eventi religiosi attraverso le caratteristiche e il volume sonoro, al quale è possibile ascrivere parte del successo di uno strumento quale l'organo, la cui sonorità profonda induce nell'ascoltatore una sensazione di presagio (l'effetto degli ultrasuoni prodotti dall'organo è documentato anche da alcuni studi scientifici).
Poiché la notazione musicale non emergerà che nel corso del II millennio, il canto cristiano dei primi secoli ci è completamente ignoto, e ciò che se ne sa deriva in gran parte da supposizioni. La sua presumibile derivazione dal rito ebraico fa presumere che la liturgia dei primi secoli fosse basata sull'intonazione di forme melodiche tradizionali costruite attraverso variazioni molto piccole (di ampiezza inferiore ad un semitono e perciò dette microtoni) e in cui il ritmo era derivato dal ritmo verbale della liturgia (questo procedimento è anche detto cantillazione. Inoltre si può supporre che la condizione di clandestinità in cui la religione cristiana era praticata favorisse il sorgere di molte varianti del rito e quindi dell'accompagnamento musicale di riferimento.
La situazione cambiò nel 380, quando l'editto di Tessalonica impose la religione Cristiana come unica religione dell'impero. A partire dal V secolo, il cristianesimo iniziò a darsi una struttura che imponeva l'unificazione della liturgia e, quindi, anche della musica che ne faceva parte integrante.Si può ipotizzare che la forma iniziale della musica liturgica fosse monodica (cioè affidata ad un solista, dalla parola greca che significa una voce sola) e basata su variazioni d'intonazione attorno ad una nota fondamentale (detta corda di recita), variazione che era dettata dalla prosodia (o enfasi) delle parole del testo sacro, nello stile musicale detto sillabico. A questo stile, che dominava la maggior parte della messa, si sovrappose col tempo un secondo stile, riservato inizialmente ai momenti di maggiore enfasi quali l'offertorio, in cui un solista intonava il testo facendo variare liberamente l'intonazione all'interno di una stessa sillaba in uno stile detto melismatico. La trasmissione della musica avveniva a questo punto per tradizione orale, e attraverso scuole di canto, la cui presenza presso i maggiori centri di culto è attestata fino dal IV secolo. Oltre alla scuola di provenienza, è probabile che anche l'improvvisazione e l'abilità del singolo cantore determinassero in larga parte la musica d'uso liturgico.
Agli inizi del VI secolo, esistevano in Occidente diverse aree liturgiche europee, ognuna con un proprio rito consolidato (tra i principali, ricordiamo il rito vetero-romano, il rito ambrosiano a Milano, il rito visigotico-mozarabico in Spagna, il rito celtico nelle isole britanniche, il rito gallicano in Francia, il rito Aquileiese nell'Italia orientale, il rito Beneventano nell'Italia meridionale). La tradizione vuole che alla fine di questo secolo, sotto il papato di Gregorio Magno (590-604) si sia avuta la spinta decisiva all'unificazione dei riti e della musica ad essi soggiacente.
In realtà si ha motivo di credere che l'unificazione avvenisse quasi due secoli più tardi, ad opera di Carlo Magno e sotto l'impulso della unificazione politica che portò alla nascita del Sacro Romano Impero. L'attribuzione a Gregorio Magno sarebbe stata introdotta per superare le resistenze al cambiamento dei diversi ambienti ecclesiastici, costretti a rinunciare alle proprie tradizioni.
Il prodotto dell'unificazione di due dei riti principali quello vetero-romano e quello gallicano fu codificato nel cosiddetto antifonario gregoriano, che conteneva tutti i canti ammessi nella liturgia unificata. Questa unificazione classificò i brani di musica sacra in uso secondo un sistema di modi, ispirati - almeno nei nomi - ai modi della tradizione greca (dorico, ipodorico, frigio, ipofrigio, lidio, ipolidio, misolidio, ipomisolidio).La riforma gregoriana sostituì lo studio dei testi alla trasmissione orale delle scuole di canto delle origini, sacrificando, oltre alle particolarità regionali (alcune delle quali, specialmente quelle di derivazione mozarabica, particolarmente ricche) e all'intonazione microtonale (che esisteva ancora nel rito vetero-romano) anche il ruolo dell'improvvisazione. Allo stesso tempo si creò la necessità di "annotare" i testi scritti in modo da aiutare i cantori ad eseguire le musiche sempre nello stesso modo, con una linea melodica che indicava la sua direzione, ascensionale o discensionale. Quest'esigenza fece nascere segni particolari (i neumi, pare nati dai gesti del direttore del coro) che, annotati tra le righe dei codici, rappresentavano l'andamento della melodia, come già detto, (ma lasciando liberi intonazione e ritmo).La scrittura neumatica divenne così la prima "notazione", da cui poi la parola "nota", musicale moderna.
La riforma gregoriana non impedì che, nel corso degli anni, le melodie monodiche di base fossero arricchite tramite amplificazioni in senso orizzontale, aggiungendo ornamentazioni alla linea melodica, e in senso verticale, aggiungendo altre voci al canto del celebrante. L'amplificazione orizzontale prese la forma di interpolazione di testi e melismi nella melodia gregoriana (tropi) o di composizioni originali a partire da particolari momenti della liturgia, in genere l'Alleluja (sequenze).
L'amplificazione verticale, che costituiva l'inizio della polifonia (dal greco: molte voci) prese dapprima la forma di una raddoppio (diafonia) della voce monodica (vox principalis), con una seconda voce (vox organalis) ad andamento parallelo e a distanza fissa (in genere una quarta o una quinta), secondo il procedimento che fu detto organum parallelo. La vox organalis (o duplum) inizialmente posta al di sotto della vox principalis, sarebbe divenuta più acuta negli sviluppi che seguirono. Il trattato Musica Enchiriadis della metà del IX secolo, dà conto dell'organum parallelo e di alcune sue variazioni che contemplano eccezioni del moto parallelo delle voci.
Il discostarsi dalla regola del moto parallelo delle voci era destinato a produrre tecniche polifoniche più complesse: tale fu, attorno al 1100, la tecnica del discanto dove alle voci, che conservano sempre distanze considerate consonanti (cioè quarta, quinta, ottava e unisono), è consentito un movimento più libero, che alterna tra il moto parallelo e il moto contrario. Nello stesso periodo, emerge una tecnica detta eterofonia, probabilmente derivata dal canto popolare, che consente al duplum di eseguire melismi mentre la vox principalis intona, con valori di durata assai prolungati, la melodia originale. Questa pratica è documentata in alcuni codici italiani del XII e XIII secolo (ad esempio il trattato d'organum Vaticano) e da documenti coevi provenienti dalla chiesa di San Marziale a Limoges (sud della Francia). A questo stile sarà dato il nome di organum melismatico.
Non furono queste le uniche alterazioni della prescrizione monodica gregoriana: nello stesso periodo e luoghi dell'organum melismatico si trovano esempio dell'uso di una voce di bordone (un'unica nota bassa che viene prolungata anche per tutta la composizione), composizioni multitestuali dette tropi simultanei in cui le voci cantano testi diversi, anticipando quello che più tardi sarà il mottetto e perfino accenni di scrittura a tre voci.
Bisogna infine ricordare che in Inghilterra nacque un tipo di polifonia molto diversa da quella del continente europeo, che ammetteva, enfatizzandoli, gli intervalli di terza e sesta, considerati dissonanti sul continente. Questa tendenza, espresse in composizioni a due (gymel) e tre voci, (falso bordone) avrebbe in seguito influenzato la musica fiamminga e si sarebbe poi diffusa in tutta l'Europa, diventando la base della musica occidentale (che si basa sulle triadi e gli intervalli di terza).
La scrittura neumatica lasciava molto all'immaginazione del lettore, e, proprio per questo, era inadatta alla trascrizione di composizioni di maggiore complessità, che mettevano a dura prova la memoria dei cantori.
bottom of page

